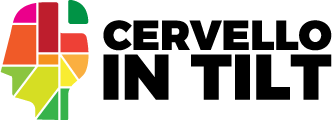Le eterne promesse

CONTESTO
Questo nella foto sono io a 14 anni.
Utilizzo la mia storia di eterna promessa, nell’accezione di Campo di Distorsione Della Realtà, termine originario derivato da Star Treck. Il termine è stato poi utilizzato da un collaboratore di Steve Jobs per descrivere il modo in cui il fondatore della Apple si rivolgeva ai suoi ingegneri, quando illustrava un nuovo progetto. Si trattava di creare un clima in cui veniva trasmesso il senso che l'apparentemente impossibile fosse possibile. Si trattava di un sistema comunicativo, del tutto naturale, di distorcere il senso della proporzione e dei gradi di difficoltà.
Io volevo diventare un calciatore professionista, un campione, a tutti i costi. Un’impresa da realizzare nel campo vero di calcio e apparentemente impossibile, visto che quando giocavo con i ragazzini in strada o nei campetti ero soprannominato “Nato Male” per la mia scarsa coordinazione motoria, le mie gambe a X e la mia estrema magrezza. A quei tempi non c’era molto da mangiare in casa mia ed eravamo in tre fratelli, sempre in agguato per rubarci il cibo a vicenda.
NATO MALE
In quegli anni si andava molto a piedi e prendevo a calci di tutto, facendo innervosire mamma. Giocare a calcio con quello che trovavo per strada era l’unica soluzione per non annoiarmi. Lei non lo sopportava e mi tirava in continuazione per un braccio. I miei due fratellini invece camminavano buoni buoni tenendosi per mano.
Passavamo tutto il nostro tempo fuori, dall’uscita della scuola fino alla sera tardi. Sempre con un pallone tra i piedi. Si giocava da soli o con i ragazzi della piazza adiacente, una piazza malfamata. Erano monelli veri e propri, un po’ più sporchi di noi e quasi tutti con i denti storti e i capelli arruffati. Se arrivavano quando era già cominciata una partitella, si mettevano in mezzo senza chiedere il permesso e decidevano chi doveva stare in porta.
La vita di strada era una semplificazione estrema di tutto. Un problema, una soluzione rapida. Violenta, pacifica, immediata, secca.
Uno dei problemi più frequenti di quel tempo lì era quando il pallone finiva sotto una delle poche auto parcheggiate. Con i missili che si tiravano, spesso il pallone s’incastrava a forza tra il fondo dell’auto e l’asfalto. I più scapestrati di noi infilavano lì sotto le gambe, cercando di liberare il pallone a forza di calci. Di solito erano quelli con le gambe più lunghe, ma anche certi monelli piccolini, per mostrare il loro coraggio, s’infilavano di testa sotto l’auto e sparivano per un tempo che a me sembrava infinito.
Non so come mai, ma tutte le volte avevo paura che il pallone fosse sparito per sempre. Che non l’avremmo più tirato fuori. Su questo mi ero proprio fissato, e senza motivo, anche perché, alla fine, il pallone si recuperava sempre. Nel peggiore dei casi era tutto sporco di morchia e, per un po’, non lo si poteva colpire di testa, ma poi, a forza di rotolare sull’asfalto, si ripuliva e lo si poteva usare come prima.
A volte toccava anche a me riprenderlo, specie se giocavo da solo o con i miei fratelli e basta. Non mi fidavo a mandare loro sotto la macchina. Il fondo dell’auto mi sembrava un mondo a sé con tutti quei tubi, l’odore della morchia e dell’asfalto e il pallone bistondo incastrato a forza.
Appena tiravo fuori il pallone, i ragazzi non mi aspettavano nemmeno un secondo. Ero svelto a uscire da sotto, ma nel frattempo avevano già fatto almeno un’azione. Nessuno riusciva ad aspettare, e non per sfruttare la superiorità numerica di una squadra, ma proprio per la furia bestia di giocare. Quella era il valore esistenziale primario. Del resto, anch’io ricominciavo subito a giocare senza aspettare, quando qualcun altro tirava fuori il pallone da sotto la macchina. Nel recuperare il pallone, la regola morale imponeva a tutti di liberarlo subito e restituirlo immediatamente agli altri. Noi della morale non ne sapevamo nulla e poco anche delle regole. E non avevamo nemmeno fatto patti, prima. Veniva naturale così. Era scontato. Quando ero più motivato, in quei giorni in cui giocare era come respirare, mi appostavo vicino all’auto, calcolando il punto più probabile di uscita del pallone per rimetterlo in gioco prima.
Poi qualcosa cambiò perché gli altri mi cominciarono a chiamare “Nato Male”, per i motivi descritti nel contesto e perché effettivamente giocavo male e allora cominciai a prendermi delle pause dal disagio di quel soprannome. Succedeva per esempio che quando il pallone si incastrava sotto le macchine, tergiversavo sempre un po’. Mi volevo calmare dal mio soprannome ripetuto e subìto di continuo. Allora baloccavo sotto la macchina. Mi piaceva il tubo di scappamento, l’unico elemento meccanico che capivo davvero bene. Sognavo di staccare i freni e causare incidenti mortali. Erano sogni brevissimi, flash di cattiveria che transitavano. Mi piaceva immaginare anche le quattro fasi del motore a scoppio. Papà le recitava come una filastrocca. Quella filastrocca, ripetuta a mente quando ero solo, mi faceva stare bene, era un mantra formidabile: Aspirazione, Compressione, Espansione, Scarico; Aspirazione, Compressione, Espansione, Scarico; Aspirazione, Compressione, Espansione, Scarico. Ed era quiete in me.
Un altro momento di distanza dal mio essere “Nato Male” era casuale: se la palla si alzava nella direzione di casa nostra, vedevo gli asciugamani del negozio di mia mamma parrucchiera stesi sul filo del terrazzo della sala, tutti colorati. Era rassicurante. Anche gli asciugamani avevano odori forti: sapevano di buono, sia da sporchi, sia da lavati, sia da appena raccolti, sia da stirati e piegati. Mi piaceva raccogliere i panni asciutti e ammucchiarli sul divano prima che mamma li stirasse, e mi piaceva anche stenderli.
Le ragazze della piazza non giocavano mai. O non c’erano o si mettevano a sedere sull’aiuola a vederci giocare, ma non che tifassero o seguissero la partita. Stavano lì senza fare niente e anche a me non importava niente di loro, non facevo il bravo per essere notato, giocavo e basta, tiravo per fare gol ed esultare. Era bellissimo esultare con un solo braccio alzato, anche se a me capitava raramente.
A completare la mia mala nascita, c’era la mia timidezza, che è l’unica promessa mantenuta, in quanto lo sono anche ora a 58, sebbene ben mascherata.
Gli episodi in cui la timidezza di allora prendeva fuoco erano principalmente due: alle elementari avevamo un grembiule nero, un colletto inamidato bianco e un bastardissimo fiocco blu di cui mi vergognavo moltissimo. Mi sentivo sempre a disagio e cominciavano i pensieri: con i miei piccoli e veloci pensieri di allora, tutto mi sembrava ridicolo, nella scuola: la merenda, i bidelli, tutti in fila per due, i canti in classe, il signor Fiduciario. Non capisco perché mi fossi fissato così tanto con quel fiocco blu ed entrassi in un loop di non sensi.
Mi vergognavo da morire anche quando entravo nel negozio di mamma e delle sue sorelle, con tutte quelle signore sotto il casco o già allo specchio, pronte per essere pettinate o per fare il colore o la permanente o il taglio o per levarsi le retine, i bigodini e le pinzette. Mi vergognavo tanto perché mamma mi faceva delle feste eccessive quando mi vedeva.
Era la mamma severa di sempre, ma esagerava con le moine e io non la riconoscevo. Mi vergognavo soprattutto perché ero al centro dell’attenzione di tutte quelle signore smontate, che facevano: Uhhhhhh vieni qua da me, uhhhhhh che bimbo meraviglioso, uhhhhhhhhh, e io che avrei voluto sprofondare il più possibile. Mi baciavano con il rossetto e avevano odori strani che non mi ricordavano né mamma né Cinzia, la mia fidanzata immaginaria. Immaginaria, perché non era affatto la mia fidanzata, ma a me piaceva pensarla così. Alcune di queste signore avevano nei scuri rilevati sul mento con un pelo aguzzo, e pinzavano come vespe quando mi sbaciucchiavano. Cinzia sapeva di asfalto, loro di plastica. Mi ricordavano l’odore della pompetta del clistere o della guarnizione della moca, pungente, falso e dolciastro. Correvo a lavarmi subito il viso.
LA TRASFORMAZIONE DI NATO MALE
In un’estate e nell’autunno seguente mi trasformai fisicamente. Avevo circa dodici anni e a Natale mi ritrovai alto un metro e ottanta, sempre magrissimo, veloce di gambe e di cervello. Non ebbi più nessuna titubanza: in piazza e nella prima squadra di calcio che mi accolse nelle sue fila come calciatore di nome e di fatto, con il cartellino e la mia firma, non ce ne fu più per nessuno. Nato Male era diventato Jeeg. Infatti a 14 anni, alla fine della stagione con la prima squadretta locale mi acquistò la Fiorentina, squadra di Serie A.
Nell’accezione del Campo di Distorsione della Realtà, in cui in cui il senso che l'apparentemente impossibile fosse possibile, divenne mio. Ero considerato da tutti la nuova grande promessa del calcio italiano.

LA FINE DELLA PROMESSA
Dopo quattro anni di dominio, mi innamorai di Elda e la pensavo sempre. Era bellissima. Mi sentivo a disagio con lei perché aveva due anni e mezzo più di me ed era la ragazza più bella di Lucca. Io facevo quattro allenamenti alla settimana a Firenze più la partita la domenica. La sera a letto alle ventuno. L’unico modo era pensarci mentre giocavo. Soprattutto quando la palla andava fuori, sfruttavo quei cinque, sei secondi per immaginarmela al mare, abbronzatissima, con un foulard al posto del reggiseno del costume, che lasciava intravedere il mondo del piacere infinito.
Intuivo che tutto questo era in conflitto con il mio voler diventare un campione.
Tornò fuori tutta la mia sensibilità esagerata, la mia timidezza, la voglia di passeggiare con lei mano nella mano, la voglia di baci come pioggia battente.
Ebbi la certezza della fine della promessa quando, in occasione delle fasi eliminatorie di un torneo internazionale, feci volontariamente un autogol per fare eliminare la Fiorentina contro la Juventus, in modo da tornare subito a casa da lei.
MORALE
Tutte le promesse mancate, i campioni in potenziale, quelle che smettono subito la loro carriera o la riprendono a singulti, sono persone mal collocate rispetto al proprio assetto psicologico. Con i miei sentimenti, con la mia timidezza, con la mia voglia di baci, il cervello andava in tilt e mi inchiodava in una crisi senza fine. Come quando sei aggrappato ad una roccia e senti le dita che perdono sempre più forza e stai cadendo nel vuoto. Fidanzato incerto e calciatore di periferia.
In altre persone sane, il desiderio irrealizzato di diventare un professionista di cui sono evidenti a tutti le capacità, possono essere l’ansia, l’irritabilità, il malumore, il timore del giudizio altrui, i falsi scopi come il denaro, la scadente capacità relazionale, la sensibilità eccessiva.
La conseguenza è che si diventa psichiatri, ingegneri, operai, baristi per un bivio preso nella direzione contraria. La vita va avanti lo stesso, ma l’esercito dei mal collocati aumenta, con un grado di malessere variabile a seconda dell’assetto cognitivo di ciascuno.
Per me, visto che ho utilizzato la mia storia, niente ha dato e darà più la stessa gioia di un goal decisivo o di un anticipo secco di cinque metri.
Altre gioie, più piene, più significative hanno preso il posto di quella sperata, ma mai avranno la stessa leggerezza.