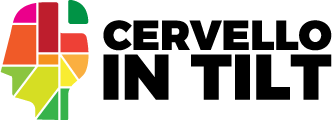Il senso della vita

Oggi Gesù riposa in pace nel sepolcro tra i suoi cari, ma non sente niente.
È morto, pur profumato di unguenti è morto.
Punto e basta.
Per la prima volta nella mia vita mi sembra strano, anche se farò le cose di sempre. In un tentativo di inutile espiazione, riporto gli attimi in cui ho perso la fede per riguadagnarla proprio ora, nell’estensione mentale concessami da una dieta brutale quanto logica e con un alieno fatto di puro amore a girare per la casa. Le copio pari pari da un mio scritto di qualche anno fa.
“Ci sono tre momenti precisi in cui ho preso il largo da voi e dagli insegnamenti cristiani di mamma, dalla frequentazione delle messe e da tutto il resto delle preghiere.
Il primo momento avvenne durante la celebrazione di una messa mattutina, in occasione di un ritiro spirituale per cresimandi. Era una chiesina di montagna e il sacerdote non un granché. Pasticcione nel preparare la mensa del Signore, pessimo oratore. Ero già maldisposto, perché abituato a sacerdoti di alto profilo, colti e rampanti. Mi avvicinai alla comunione con un raccoglimento superficiale, adeguato al basso livello della celebrazione. Aprii le labbra per ricevere il corpo di Cristo e le dita cicciotte del sacerdote m’infilarono in bocca un pezzo di ostia inzuppata nel vino rosso. Un evento insolito e inaspettato, perché la sacra commistione era riservata al celebrante e, di solito, con vino bianco. Caddi nello sgomento e nella confusione, travolto da un sapore da osteria che mi ricordava l’alito di mio nonno materno che era un beone. Non sapevo se quello schifo che mi trovavo in bocca era la risoluzione del mistero della fede o se il corpo e il sangue del Signore avevano scelto, per rivelarsi, una location di basso profilo, e che il loro effettivo sapore fosse quello. Non capivo più niente. Corsi fuori dalla chiesa e nel freddo del primo mattino, vomitai senza ritegno. Piegato in due, vomitai tutto. Quando riaprii gli occhi, percepii le Alpi Apuane lì davanti minacciose, cupe e bibliche, come mai le avevo percepite guardandole dalla spiaggia. Dal mare sembravano montagnette simpatiche, sorelline delle Alpi vere che vedevo nel sussidiario della scuola. Quella mattina, terrifiche, mi avrebbero inghiottito volentieri nei loro crepacci di marmo, reo pubblico di avere vomitato sul prato, il corpo e il sangue di Nostro Signore.
Il secondo momento d’inversione mistica, isolato e a ciel sereno, avvenne durante la messa di domenica delle dieci e trenta, la più gettonata insieme a quella delle dodici. Ero molto raccolto in preghiera, con le mani giunte e il viso vicino alle mani, secondo un’inclinazione precisa del busto. Quella posizione, trovata dopo molti tentativi, era ideale per il mio raccoglimento profondo, là dove sentivo di poter avvicinarmi di più a Dio, o a qualcuno dei suoi. Flettendo leggermente il capo verso le mani, le sensazioni provenienti dalle persone intorno e dall’intera chiesa, si azzeravano e rimanevo lì in attesa di qualcosa di buono. Un buon pensiero, una sensazione di bontà e di apertura verso gli altri, un piccolo supporto alla fede per quelle cose sante che non riuscivo a vedere, toccare o odorare. Abituato alla piazza, per me era difficile astrarmi e credere a qualcosa di così rarefatto da nascondersi nell’aria. Quella domenica non ero riuscito a concentrarmi molto e avevo voglia che la messa finisse alla svelta per andare a giocare a qualsiasi cosa. Rialzando la testa dal mio raccoglimento, ebbi una visione sconvolgente e che a me sembrò lunga un’eternità. Tutti i fedeli avevano la testa di pecora, uguale precisa a quelle delle pecore di Giotto dietro alla scatola delle matite. Vestiti normali, bipedi, con le mani giunte, ma tutti con la stessa testa di pecora giovane. Non riuscivo a rinfilare la testa dentro le mie mani giunte, come avrei dovuto fare immediatamente per riprendere il contatto con un Dio più assennato e sobrio. L’immagine svanì da sola con il brusio di tutte le pellicce e dei capelli cotonati delle signore.
L’altro momento simbolo del crollo della mia fede lo ricordo intorno ai quattordici anni, ormai baciatore vaccinato. Sempre messa delle dieci e trenta, stranamente lontano dall’altare, in decima fila, con mamma accanto. Era il momento della consacrazione e mamma era ancora calma. L’avvicinarsi della Comunione la rendeva frenetica e vedevo che faceva dei passetti di lato e poi metteva un piede sull’inginocchiatoio, poi prendeva il librettino delle preghiere, poi lo posava, poi si guardava intorno. Gli altri fedeli erano ormai diventati momentanei rivali nella sua corsa verso il corpo di Cristo. Mamma conosceva bene i suoi avversari, le solite quattro o cinque fanatiche che, come lei, si lanciavano nello sprint mistico. Noi tre fratelli aspettavamo la Comunione per vedere chi sarebbe stato il fedele più veloce e mamma vinceva spesso, assaporando il gusto della prima ostia consacrata. Mamma era fortissima allo sprint. Noi stavamo per lei. Dalla decima fila era un’impresa difficile, ma a volte ha vinto anche partendo dalla porta della navata centrale, con una volata lunghissima e possente che non lasciava scampo a nessuno.
Alla consacrazione dell’ostia, mamma stava ancora tranquilla, in mezzo al gruppo dei fedeli, e ondeggiava nei canti innescati da un musicista d’organo che a me sembrava molto strano e che noi tre chiamavamo Bach di soprannome, sbeffeggiandolo. Come nell’episodio delle teste di pecora, avvenne tutto in un istante, senza preavviso. Lasciai i miei vestiti della domenica alla realtà e in un sogno ad occhi aperti, indossai una tuta mimetica che avevo visto in caserma, quando di nascosto entravo nel portone. Con questa mimetica mi sentii un soldato in piena regola e con il mio moschetto, mi stesi per terra nella navata centrale, nel corridoio di passaggio dei fedeli. Atteggiato a cecchino, guardavo l’ostia alzata al cielo, in proiezione obliqua rispetto al tabernacolo, diversi metri dietro il celebrante. Vedevo l’ostia precisa dentro il mirino, che con i suoi riferimenti la divideva esattamente in quattro. La potenza del mio proiettile contro l’esiguità di un’ostia, sia pure consacrata, non lasciava scampo a quel povero cristo che la stava santificando da dentro.
Fermato da presentimenti oscuri, ma che oggi ho chiarito in funzione dell’amore, non sparai, come Robert De Niro al cervo nel film “Il cacciatore”. Lasciai andare Gesù dentro l’ostia, lo feci ridiscendere nel calice, dove da lì a poco, il prete avrebbe versato il vino, a detta di Gesù, il suo stesso sangue, in un miscuglio piuttosto caotico di simboli e santità. Riposto il fucile, ero tornato lindo e pulito a proseguire la messa. Guardavo mio fratello di mezzo che aveva i capelli tutti leccati e tenuti insieme da una molletta. Mamma a volte esagerava con l’estetica.