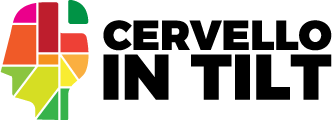Il senso della vita

Da dieci anni mi sono trasformato in un divano. Un divano a tre posti in alcantara blu. La mia ex faccia, ma soprattutto la mia ex testa, sono per così dire diluiti nel cuscino di destra. Le altre parti del mio corpo sparse qua e là, nel resto del divano. La metamorfosi è stata improvvisa. In una sola notte ho cambiato definitivamente status: da homo sapiens a divano a tre posti in alcantara blu, ossia il sofà di casa. Mutare in sostanza inanimata non mi è stato doloroso, né sofferenza mi provoca la staticità cui sono costretto. Sono da sempre un pigro.
Questo è stato un evento davvero insolito ed estremo, anche se la mia è una famiglia predisposta alle trasformazioni, o meglio, alla coesistenza di elementi tipicamente umani con altri estranei alla specie.
Per fare un esempio, la mia prima moglie, persona di un equilibrio unico, aveva all’interno della schiena tre elementi verticali che le andavano dal bacino alla linea delle spalle: tubi cavi, di piccolo calibro (5 centimetri di diametro), uniti tra loro alle estremità da un piccolo condotto orizzontale, sempre cavo e comunicante con gli altri. Un sistema chiuso in ghisa, che lei si teneva lì dalla nascita e che non le ha mai creato problemi di salute. La peculiarità di questo sistema è che si scaldava a comando. Un’apparente bizzarria, che ha sempre sconvolto la rigidità della medicina ufficiale, ma che si è rivelata molto utile nel tempo, soprattutto per me.
Sono, anzi ero - prima di diventare sofà - un tipo molto freddoloso. Quando il freddo mi entrava nelle ossa non riuscivo più a ragionare e, qualsiasi attività, anche la più piacevole, mi risultava ostile. In questi casi ricorrevo a mia moglie d’urgenza. Le appoggiavo i piedi congelati sulla schiena e, in breve, mi scaldavo tutto, baldanzoso e un po’ sopra le righe, come da scampato pericolo.
In questi dieci anni ne ho viste e sentite di tutti i colori, ma se c’è una cosa che non potrò mai dimenticare è la prima notte da divano, passata in bianco, preoccupato, come un uomo qualsiasi, delle reazioni dei miei familiari. Nessuno, infatti, poteva spiegare loro che io ero sempre lì, addirittura più di prima, che non mi sarei letteralmente più mosso di casa. Chi avrebbe dato loro una ragione della mia scomparsa senza lasciare una traccia? Chi li avrebbe convinti che non ero stato né rapito, né ucciso, né tanto meno fuggito con una donna?
La psicologia del divano non è la stessa dell’uomo. Non si potevano pretendere da me, già in prima notte, ragionamenti in alcantara. Mi preoccupavo esattamente come fossi stato in carne e ossa. Ci stavo davvero male e le cerniere dei cuscini mi soffocavano. Fino alle tre è stato un vero e proprio massacro. Poi mi sono arreso all’evidenza. Nessuno dei miei passeggiava nervosamente per le stanze, nel tipico atteggiamento dell’aspettativa ansiosa. La notte era molto quieta e standard. Barbara era rientrata verso le quattro dopo aver disidratato il fidanzatino. Come sempre aveva sbattuto il portone di casa, con un surplus di energia residua. Poi, tutto era tornato silenzioso. Per diluire la sorpresa dell’assoluta tranquillità dei miei, non mi è rimasto che fissare la spia luminosa del televisore, cosa che del resto facevo anche nella versione homo, nelle notti insonni sine materia.
Non mi ero sbagliato. La prima impressione si è consolidata nelle ore, nei giorni, nelle settimane, nei mesi e negli anni seguenti, fino ad oggi, giorno di trasloco. In tutto questo tempo, nessuno si è accorto della mia assenza. Nessuno. Nemmeno il minimo riferimento, anche casuale.
Per dire, quante volte si sono seduti su di me per vedere una partita? Vengono sempre tutti qui, il mio salotto è diventato un ritrovo. Che non gli sia mai venuto in mente che ero coordinatore tecnico in una squadra di Serie A? Passi che non ragionavo ancora da divano, ma non riuscivo ad abituarmi alla loro amnesia. Non avrei certo preteso che si parlasse sempre di me; anche nella condizione umana non ero mai stato il classico accentratore, il divoratore di palcoscenici; anzi, mi ero quasi sempre nascosto dalla luce diretta dei riflettori. Anche alle cene (le poche cui ho partecipato) mi mettevo sempre defilato. Ma almeno un ricordo affettuoso, o una piccola citazione di una gag delle mie, me la sarei aspettata, mi avrebbe fatto piacere. Invece niente. Lo zero assoluto. Credo proprio che se non fosse stato per la solidità della mia nuova struttura, sarei andato rapidamente in malora.
Pensavo a queste cose della Serie A e dei piccoli ricordi che avrebbero potuto evocare senza sforzo alcuno: ma allora che dire di tutti i valori affettivi e morali, della mia presenza attiva, del mio interventismo educativo e di tutte quelle cose che al tempo divulgavo, sì quelle cose… progettualità… obiettivi… efficienza… evoluzione…
Al ritmo della luce, variata dall’inclinazione delle tende, mi consolava il fatto che li vedevo sereni. Non parlavano di me, ma stavano bene. Anche gli ospiti occasionali, i miei fratelli, Silvia, che per fortuna lasciava il coniglio a casa, colleghi fanatici di mia moglie, sua sorella Rita, tutti proseguivano sulle loro solite strade. Ed era tutto talmente come sempre che, nonostante i miei pensieri fossero diventati un poco più sintetici (nel senso chimico), ce la facevo benissimo a seguire le loro conversazioni, i loro piani, i tempi delle loro battute, le aperture e le chiusure caratteriali di ciascuno. Anzi, il fatto di essere distaccato, mi permetteva di capirli molto più di prima e di volergli quasi più bene.
Il mio nuovo punto di vista si è rivelato subito particolare. Lo era anche prima, ma non così. Prima di tutto i colori. Inevitabilmente tutto tendeva alla monocromia. La mia visuale aveva anche prospettive differenti, sviluppate soprattutto in verticale come una chiesa gotica. Blu. La scansione sinistra era limitata dallo schienale, mentre la destra compensava ed era capace di percezioni nuove e interessanti. Come quando si sedevano su di me le amiche coccigee di mia moglie. Ma queste sono questioni di poco conto.
Il vero, unico problema patito nel trapasso, era stato quello della sudditanza psicologica. Ai miei tempi questo era un concetto legato alla classe arbitrale, e si riferiva a un atteggiamento compiacente dei direttori di gara nei confronti delle grandi squadre. Con tutto il rispetto, la vera sudditanza psicologica era la mia, costretto a farmi montare addosso da tutti. Senza offesa, ma la prassi del sedere sulla faccia, al di fuori di contesti specifici, non è situazione facile da digerire. Le persone poi, e ci faccio caso adesso, non trattano allo stesso modo divani e sedie. Su di me - e penso sui miei attuali colleghi - la gente si butta a peso morto, con una potenza d’urto che è uguale al loro peso moltiplicato per i fattori che regolano la caduta dei gravi. Il problema non era lo schiacciamento. La mia sensibilità dolorifica era mutata alla perfezione, le vie nervose sostituite da robuste fibre. Moralmente, invece, ero devastato. In questo senso non riuscivo ad adattarmi.
Tutti, anche i grilli, mi saltavano addosso che era una bellezza. Alcuni addirittura facevano una cosa che i preparatori atletici chiamano contro movimento, cioè in sequenza un piccolo piegamento sulle gambe per prendere lo slancio, lo slancio e la ricaduta a piombo accelerato su di me. Mi ricordo bene quei giorni: il fastidio psicologico della mia nuova condizione era tale da oscurare il quesito di fondo che mi trapanava le fibre, quello che nessuno si accorgeva della mia assenza.
I divani non hanno autocoscienza, per cui capivo che la mia, trascinatami dietro dall’altro genere, era solo un ingombro. Sì, che poi ero uno di quelli noiosi, il tipico self-made-man per di più anche sensibile, che per venir fuori hanno bisogno d’indottrinarsi ben ben l’io e infastidire anche gli altri per rinforzare i concetti. Lo ammetto senza vergogna. Per un uomo al culmine della maturità (41 anni e tre giorni), con autocoscienza da svendere, non è stato facile e per venirne a capo ho usato un vecchio trucco carpito dalla precedente esperienza. Distrarsi, depistare se stessi. Banale quanto si voglia, ma funziona.
Distrarsi non vuol dire andare in giro a divertirsi e perdere tempo. Per me, uomo al cospetto di un problema al momento insuperabile, distrarsi voleva dire impegnarmi con tutto me stesso in un altro progetto più abbordabile. Ti muore uno, ecco non ci puoi fare niente, altro che sbattere come una furia la testa contro un muro scabro. Quando ti accorgi che l’altro è sempre morto e che tu sei sempre vivo, con l’anima sodomizzata da un treno, hai due opzioni secche: raggiungerlo o emanciparsi (linguaggio tipico del self-made-man, non racconto storie). Non era esattamente la stessa situazione, ma da neofita dell’arredamento cercai di non far caso alla prospettiva peculiare a cui ero costretto dalla mia natura mutata, concentrandomi, lavorando sodo, con i pensieri ancora vispi, sulla questione familiare. E funzionò. In poco tempo riuscii a non offendermi più delle sedute altrui e mi costruii nuovi valori, più congrui al mutato assetto.
Elisabetta mi aveva regalato in vita una poltroncina blu, davvero molto carina. Un soprammobile da scrivania. Ero tutto entusiasta perché credevo si fosse ricordata di una nostra conversazione. Della nostra unica, credo. Sì, le avevo parlato delle mie idee per l’ultima fase della vita. Le avevo preannunciato che mi sarei concesso libri e film a oltranza e tante passeggiate, a Viareggio, fuori stagione, a tutto olfatto di mare. Un progetto banale, da pensionati se si vuole, ma non le chiesi un giudizio, non m’interessava il suo. Comunicavo e basta, tanto per dare un senso a me e al pranzo.
Il blu e la poltroncina c’entrano perché, con il mio naturale debordare, le dissi che sarebbe stato il periodo blu come il colore del divano di casa mia. Quando scartai il pacchetto natalizio e vidi il simbolo della mia nuova era, mi sembrò tutto: ben augurante, sintonico, affettuoso e molte altre cose tanto sincere e tanto gentili. Quando Elisabetta mi disse che era un portacellulare e sì, che si ricordava qualcosa dei miei progetti ma che lo scopo del regalo era un altro, non ebbi nemmeno la forza di rimanerci male. Credo si chiami negazione.
Continuai a essere felice lo stesso, comunque convinto di essere stato compreso. Ne sono convinto tuttora. Prova ne è che, a dieci, anzi undici anni di distanza, conservo ancora un buon ricordo di quella bella friulana di carattere. Ora non sarebbe poi così male averla seduta qui su di me, cinque minuti prima che mi portino via per sempre.
Mio figlio Alessandro aveva ansie di separazione tipiche dell’età e del nostro DNA. Specie la sera, esternava le sue preoccupazioni sulla nostra possibile scomparsa e di come lui avrebbe potuto affrontare il mondo da solo. Lo confondevo subito con scherzi e frasi insensate che lo facevano ridere, ma la sua bella fetta di disagio se la doveva ingozzare quasi ogni sera. Averlo visto crescere senza intoppi particolari, anche senza di me padre accanto, mi è servito molto. Non provo nemmeno a pensarmi bagnato dalle sue lacrime per me che non c’ero più. E nemmeno voglio pensarmi colpito dai suoi pugni di rabbia per un padre dileguatosi nel nulla. Paralizzato in queste forme fisse sarei andato in malora, come un divanetto da quattro soldi. Non è andata così, per fortuna. Eccolo qui il mio ragazzino. Il mio quasi uomo. Il torpore adolescenziale sempre appresso, l’ho visto crescere bene, il suo pensiero gentile e articolato, capace di arrivare al nocciolo delle questioni in breve. Un bel cerbiattino davvero. E i miei momenti più belli li passo con lui. Sempre più spesso da soli in casa, Ale si sdraia su di me con un libro di materie insulse tipo storia o geografia. Faccio di tutto per farmi trovare sempre morbido e accogliente e lo avvolgo in spire morfeiche fino a fargli cadere il libro sul pavimento. Lo sento rigirare, mettersi a pancia in giù e abbracciarmi forte quando il caso concede la giustapposizione con il cuscino di destra. Avverto le sue guancine scavate da Antinoo, percepisco le sue gambe lunghissime oltrepassare il bracciolo opposto e il suo cuore sfacciato mettere in vibrazione il mio sistema di molle piatte. Attutita dai cuscini, già parte di me, ogni sua sistole piena si trasmette cupa e costante al mio scheletro metallico, che risuona disomogeneo ma vivo, per dio, vivo.